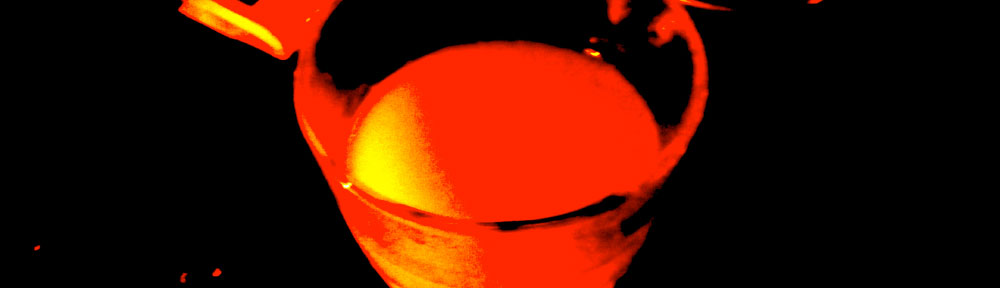A Beijing, Pechino. Ragionando, da sobrio, su come fosse possibile che stare lì fosse normale
Qualche giorno fa sono stato invitato a parlare del mio viaggio intorno al mondo con bici autocostruita, parte di un ciclo di discorsi su -e racconti di- viaggi in bici nato da qualche mese per iniziativa di un negozio specializzato che per un caso è proprio sotto casa mia, non più di otto passi. Il viaggio di cui avrei dovuto parlare risale a quattro anni fa ed era una delle idee sceme o potenzialmente autolesioniste che mi vengono di tanto in tanto in mente. A metà dei 48 anni avevo realizzato che si alzavano di parecchio le probabilità di compiere mezzo secolo, e nell’istante stesso in cui pensavo “come mi festeggio?” è stato naturale rispondermi “giro del mondo con una bici fatta da me”.
Non pensavo da un po’ a quel viaggio e provo qui a spiegare perché. E’ necessario premettere alcune cose: avevo a disposizione sei mesi di aspettativa, quindi non vi aspettate che abbia circumbiciclato il globo per intero, tutt’altro: treni -tra cui la Transiberiana, meravigliosa e uno dei miei sogni da ragazzo- e aerei transoceanici mi hanno dato le spinte giuste per tornare a casa entro il tempo prefissato. Mi ero dato quattro mesi, perché mi conosco e da altri viaggi lunghetti fatti in precedenza pronosticavo un certo periodo di recupero per tornare nella realtà di tutti i giorni. Allo stesso tempo, da quando ho cominciato a muovermi esclusivamente in bicicletta e ho abbandonato il mio ex amore motocicletta, grossomodo nel 2002, quasi subito ho avuto la sensazione di essere entrato in una dimensione di viaggio permanente. Era quindi arrivato il momento, tra l’altro, di verificare sul campo quella sensazione latente e forse ingannevole.
Nel secolo scorso avevo fatto altri viaggi in bici, generalmente in posti scomodi e desertici, e regolarmente al ritorno ero un disadattato. Ovviamente avevo viaggiato anche in moto, e il disagio del ritorno era sempre lì ad aspettarmi, identico. Non avevo quindi la prova che la sensazione di viaggio perenne, una volta trasformatomi in ciclopiteco sapiens, fosse la realtà. A farla breve è invece stato così.
Però non pensavo più a questo aspetto, me ne sono ricordato solo perché uno degli intervenuti, prima che iniziasse la chiacchierata, mi aveva chiesto appunto se ero tornato frastornato dal viaggio. Nelle due ore successive però la discussione si è sviluppata su direttrici diverse: come si fa la doccia in Transiberiana, quanto costa il sushi in Giappone, le ciclabili di Pechino larghe 20 metri, se l’acqua di Cuba è buona, che tubazioni ho usato per costruire il telaio, organizzazione dei bagagli. Cose così.
Mentre parlavo pensavo a quanto sia identico fermarsi a un chiosco cubano a bere acqua di cocco o piegarsi su un “nasone” romano a bere acqua; andare a mangiare shawarma in un posto qualsiasi della mia città o borsh a Sukhebator (Mongolia), okonomyaki a Hiroshima vicino all’ostello, qualsiasi altra cosa quando ne senti il bisogno o la voglia. Non cambia niente, né cambia il modo di relazionarsi con chiunque incontri: in linea di massimo cortesia, benvenuto visitatore, che bel posto questo in cui vivete, e come vi va, ma sai abbiamo problemi però dài tutto si risolve; le chiacchiere usuali che facciamo un po’ tutti un po’ dappertutto, a casa o fuori casa. Una piacevole e non banale sensazione di appartenenza a questa pazza specie che vive ovunque su un pianeta piuttosto periferico e solitario.
Ne volevo parlare alla fine, ma poi è piombata come una meteora la notizia che a Roma il consiglio comunale aveva deliberato di intitolare una via ad Almirante, e siamo tutti tornati a soffrire la triste realtà dei nostri luoghi in questi tempi. La riunione si è chiusa in un lampo, sotto il peso dello sconcerto. Però mi era rimasto questo messaggio inespresso a mezza gola, e lo racconto ora.